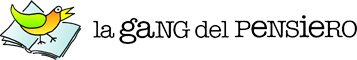Una storia d’amore.
Una volta amavo tantissimo un uomo.
Facevo per lui tante volte su e giù per le scale e per le strade e anche nel cuore, tutto andava su e giù.
Capitava che per un niente litigassimo, quasi sempre per motivi di orgoglio o di principio, e allora per mesi non ci parlavamo più.
Un giorno partì addirittura per la Cina, pur di non vedermi.
Lo aspettai, come si aspetta qualcuno di importante, un profeta, un re. Quando fece ritorno ricominciai ad amarlo, ancora di più, dato che era stato in Cina.
La Cina, mi diceva il mio amore, non è come la dipingono, esotica e piena di saggezza, la Cina è piena di cinesi tristi – diceva il mio amore.
A me la Cina era sempre sembrata un posto esotico e pieno di saggezza, quindi spesi diverso tempo a cambiare, in me, tutti i cinesi, a rompere vasi, a far diventare la Cina come diceva lui: un discount di tristezza. Ruppi tutti i giardini, e stracciai le vesti dell’imperatore, per amore del mio amore.
Poi, un giorno, un giorno come tutti gli altri, di buon mattino, il mio amore sparì. Pensai, sarà tornato in Cina. Ma non era in Cina. Pensai, sarà andato a vedere il mare. Erano molti anni che non vedeva il mare. Ma non era andato a vedere il mare. Allora niente, mi dissi, sono spacciata.
E continuai a vivere come nulla fosse, ma senza di lui.
Queste storie di solito finiscono in un modo esemplare, o bene o male, sempre con una piccola sorpresa; ma la mia storia, la storia di me e di quell’uomo che amavo tantissimo, non è finita.
È rimasta incastrata in qualcosa, un filo, un sasso, qualcosa che non le permetteva di andare né avanti né indietro, né su né giù. È rimasta ferma. Incastrata. Come tutte le cose incastrate è rimasta tale e quale a come la ricordiamo: insolita e splendente.
Una volta amavo tantissimo un uomo. Lui anche diceva di amarmi, ma non tutti i giorni della settimana, solo di lunedì e di sabato. Il sabato soprattutto, quando mi apriva la porta, sogghignava, e mi diceva Entra, ti ho appena fatto il caffè
A volte mi sedevo vicino a lui e guardavamo insieme le cose appese, le cose appoggiate, e anche le cose fuori dalla finestra della sua casa. Lui sapeva le cose in un modo, che a me non sembrava possibile saperle così.
Sapeva Platone. Si ricordava Aristotele per filo e per segno. A me piaceva, quando camminavamo, soprattutto se c’erano dei fuochi, dei falò, ma anche se c’era la neve, chiedergli qualcosa su Aristotele. Lui parlava, e io pensavo: tutti questi passi nella neve non li dimenticheremo mai. È nato un amore molto bello. È stato un tipico amore di gioventù.
Un giorno, molti anni dopo ci siamo incontrati, non per caso, eravamo nella stessa stanza. Io sapevo che lui era lui, che lui doveva essere proprio quel lui che, molti anni prima, aveva dentro tutto: le categorie, la fisica, l’etica nicomachea e il mio cuore.
Gli guardavo le scarpe, perché le scarpe, pensavo, una cosa come un’altra. Cercavo di essere normale, ma ero normale. Facevo finta di niente, ma era niente.
Eravamo diventati così bravi, così normali, che non c’era neanche bisogno di fingere. Bevemmo un caffè orrendo. Un caffè schifoso, parlando di un progetto regionale di un piano regolatore di un settore amministrativo statale a partecipazione europea.
E poi lui mi sorrise, e anch’io gli sorrisi, come si sorride a un palo della luce, a un alce, a un igloo. Ma nessuno, di quelli che erano intorno a noi, vide la cosa, si rese conto di quel disastro, di quella catastrofe universale.
Fu tutto, come se non fosse stato.
E in pochi minuti, una gomma enorme, cancellò secoli di storia, e alberi, e generazioni di pensatori e le stelle e il globo terrestre, e rimasero soltanto un tavolo, alcune sedie e un posacenere.
Le nostre mani non si sfiorarono, i nostri occhi si guardarono bene dall’incrociarsi.
Fu tutto come doveva essere, secondo il tempo e le stagioni, lui scordò il mio nome, io il suo.